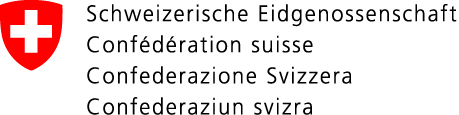Durante la Prima guerra mondiale la Svizzera è sconvolta dalle difficoltà di approvvigionamento e dalla scarsità di manodopera. Grazie al loro impegno durante il conflitto le donne svolgeranno un ruolo essenziale per il buon funzionamento del Paese, gettando le basi per le loro rivendicazioni e la valorizzazione della loro partecipazione economica.
A causa della mobilitazione generale del 1914, i ruoli nei diversi settori di attività vengono ridistribuiti. In assenza dei mariti e dei figli, le donne si vedono costrette a sostituire gli uomini laddove necessario. Il soldo e le rare indennità dei cittadini chiamati alle armi non sono tali da permettere alle loro famiglie di vivere dignitosamente, ragion per cui la femminilizzazione del lavoro risulta essere fondamentale.
Un impegno non del tutto nuovo
La presenza femminile in questo contesto di tensioni economiche varia a seconda del settore. Mentre gli agricoltori mandati al fronte possono contare sulle mogli o sui genitori per garantire lo sfruttamento delle loro tenute, la situazione dei lavoratori dipendenti è ben diversa. Nel settore secondario, in particolare nell’industria orologiera, le donne sono già parte integrante delle fabbriche: tra l’inizio del secolo e il 1910 rappresentano circa un terzo della manodopera, numero che salirà a circa il 40% nel periodo interbellico.

Le due SAFFA
SAFFA è l’acronimo tedesco di «Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit» (esposizione nazionale svizzera del lavoro femminile). Con questa sigla s’intendono le due esposizioni organizzate rispettivamente il 1928 a Berna e il 1958 a Zurigo da alcune associazioni femministe. La prima mette in risalto la donna e le sue difficili condizioni di lavoro nella Svizzera del dopoguerra, presentando allo stesso tempo i vantaggi del lavoro femminile per l’economia. Già in questa occasione il suffragio universale riscontra una vasta approvazione. La seconda esposizione è incentrata sulle possibilità di lavoro e formazione per le donne e sul consumo in generale. Inoltre, viene messo in luce il contributo essenziale delle donne al buon funzionamento della nazione.
Tre attiviste fondamentali
Ognuna a modo suo, Margarethe Hardegger, Dora Staudinger e Else Züblin-Spiller si sono adoperate affinché venissero riconosciuti i diritti delle donne in questo periodo storico.
Margarethe Hardegger si è sempre battuta per l’emancipazione femminile. Nel 1904 fonda il suo primo sindacato e due anni dopo diviene la prima segretaria dell’Unione sindacale svizzera (USS). Lotta contro le disuguaglianze sociali e lo sfruttamento lavorativo, le cui vittime sono principalmente le operaie. Le sue idee sono lungi dall’essere convenzionali per l’epoca: difende la libertà sessuale, il diritto alla contraccezione e all’aborto. In quanto pacifista, è favorevole alla soppressione dell’esercito. Dà vita a delle comunità agricole ed è impegnata nella lotta per il suffragio universale.
Inizialmente giornalista politica, Else Züblin-Spiller si dedica poi alla lotta contro la povertà. Nel 1914, anno in cui scoppia la Prima guerra mondiale, fonda la Società svizzera per il benessere dei soldati, che offre pasti equilibrati a prezzi modici e senza alcol all’interno di apposite strutture di accoglienza. Sulla stessa falsariga, organizza delle mense nelle fabbriche. Nel 1916 istituisce il servizio d’assistenza al soldato. S’impegna inoltre nel movimento femminista incoraggiando le donne a lavorare, e partecipa alla SAFFA.
Dora Staudinger è un’attivista tedesca trasferitasi a Zurigo nel 1912. È una delle poche donne in Svizzera ad aver svolto un ruolo importante nel movimento per la riforma delle abitazioni, in particolare all’interno della cooperativa Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), fondata nel 1916. Nel 1913 istituisce la prima commissione femminile in seno alla cooperativa di consumo di Zurigo. Dopo aver aderito nel 1914 al partito socialista, nel 1915 crea con Clara Ragaz il ramo svizzero della Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà. Inoltre, si batte affinché vengano presi in considerazione i bisogni delle casalinghe.
Bibliografia e fonti
- De Weck, Hervé; Roten Bernard. Jura et Jura bernois pendant la Première Guerre mondiale. Porrentruy: Editions D+P ; Société jurassienne des officiers, 2017.
- Lachat, Stéphanie. Les pionnières du temps : vies professionnelles et vies familiales des ouvrières de l’industrie horlogère suisse (1870–1970). Neuchâtel: Edtions Alphil-Presses universitaires suisses, 2014.
- Voegeli, Yvonne. Saffa. In: Dizionario storico della Svizzera [online]. Versione del 07.06.2016.
Su Margarethe Hardegger
- Bochsler, Regula. Ich folgte meinem Stern: das kämpferische Leben der Margarethe Hardegger. Zürich: Pendo-Verlag, 2004.
- Bochsler, Regula. Margarethe Hardegger. In: Dizionario storico della Svizzera [online]. Versione del 21.01.2021.
- Boesch, Ina. Gegenleben: die Sozialistin Margarethe Hardegger und ihre politischen Bühnen. Zürich: Chronos-Verlag, 2003.
- Schindler, Patrick. Vie et luttes de Margarethe Faas-Hardegger : anarchiste, syndicaliste & féministe suisse : pour le centenaire de « L'Exploitée », 1907–2007. Paris: Editions du Monde libertaire, 2007.
Su Else Züblin-Spiller
- Ludi, Regula. Else Züblin-Spiller. In: Dizionario storico della Svizzera [online]. Versione del 12.04.2021.
- Schnyder, Moia. Zwei Pionierinnen der Volksgesundheit: Susanna Orelli-Rinderknecht, 1845–1939; Else Züblin-Spiller, 1881–1948. Wetzikon: AG Buchdruckerei Wetzikon, 1973.
- Parzer-Epp, Verena. Else Züblin-Spiller (1881–1948). In: Pionnières de la Suisse moderne : des femmes qui ont vécu la liberté. Genf: Slatkine, 2014, S. 221–223.
Su Dora Staudinger
Ultima modifica 18.11.2021
Contatto
Biblioteca nazionale svizzera
SwissInfoDesk
Informazione dell'utenza
Hallwylstrasse 15
3003
Berna
Svizzera
Telefono
+41 58 462 89 35
Fax
+41 58 462 84 08